Nel contributo apparso su Scuola 7 del 2 febbraio 2025, si è voluto sottolineare, per la vita democratica del nostro Paese, quanto sia grave e preoccupante la carenza di conoscenze fondamentali della storia del Novecento da parte delle studentesse e degli studenti della scuola italiana.
Anche per questo motivo, abbiamo insistito sullâopportunità di introdurre alcuni elementi essenziali (gli elementa) dello studio del XX secolo, a cominciare dalla scuola primaria.
Il curricolo, infatti, è un percorso che accompagna lâalunna/o dalla scuola dellâinfanzia alla conclusione dellâintero ciclo scolastico ed è realmente formativo, nel momento in cui assicura non tanto uno studio estensivo di molti contenuti, quanto un approccio critico e interpretativo. Dunque, non uno studio di âsuperficieâ, ma di âprofondità â.
I saperi di responsabilitÃ
Lâesigenza di abbandonare una visione enciclopedica del sapere scolastico veniva già sollecitata nel Documento dei Saggi, elaborato nel lontano 1997 da un gruppo di lavoro voluto dallâallora ministro Luigi Berlinguer.
Alla domanda âQuali saperi affidare alla scuola rispetto ad una società sovraccarica di informazioniâ, Maurizio Bettini, filologo classico e antropologo, rispondeva che occorreva rifarsi non ad un elenco di contenuti o a una serie di discipline, ma ad un principio: la scuola deve investire sui âsaperi di responsabilità â, cioè su quelle conoscenze finalizzate ad accrescere la consapevolezza civica delle persone. Questa finalità costituisce un compito precipuo della scuola. Lâintroduzione dellâinsegnamento dellâeducazione civica (legge 92/2019) ha colto, in parte, lâimportanza di questa istanza. Ad ogni cittadino, infatti, indipendentemente dalla classe sociale, dalla collocazione geografica, dalla ricchezza o meno della comunità nella quale vive, devono essere assicurati gli âstrumentiâ di una cittadinanza necessari allâaffermazione di un orizzonte di libertà , di partecipazione democratica, solidarietà e, soprattutto, di responsabilità civico-sociale.
Partire dalla Costituzione
Oggi può sembrare fuori luogo, nellâera della rivoluzione informatica, ipotizzare lo studio del XX secolo, richiamandosi ad una Carta elaborata e approvata quasi ottanta anni fa. Câè però più di una ragione per sostenere che essa possa costituire lo sfondo di un curricolo del Novecento sia nella scuola di base (3-14 anni) che nellâistruzione secondaria di secondo grado.
LâItalia, nel quadriennio 1945-1948, ha voltato pagina, aprendo unâepoca completamente nuova rispetto alla monarchia sabauda e alla dittatura fascista. Il 1° gennaio 1948 segna, pertanto, uno spartiacque tra la storia di una âvecchiaâ Italia e quella di un Paese che avrebbe occupato, nellâarco di qualche decennio, un posto di primâordine nel consesso mondiale.
La Costituzione ha instaurato, per la prima volta nel nostro Paese, uno Stato di diritto, forma istituzionale indispensabile di una democrazia avanzata. Però lâimportanza di questo requisito è oggi poco compresa e anche messa fortemente in discussione (sia in America sia in Europa).
Ã, dunque, necessario che la sua difesa sia accudita e promossa da ogni singolo cittadino, sin dalla più tenera età . I bambini, a cominciare dalla scuola primaria (anche infanzia), non possano ignorare il nostro recente passato.
Unâessenziale conoscenza dei fatti che hanno segnato la storia del cosiddetto âsecolo breveâ (Hobsbawm, 1991) costituisce una delle principali condizioni affinché ragazze e ragazzi possano agire con coerenza, ponendo le basi di unâeffettiva convivenza civile e democratica.
Esempio di democrazia nella scrittura collettiva della Costituzione
In un quadro più generale, va sottolineato che i padri costituenti hanno dato una dimostrazione di grande maturità politica e giuridica; sono riusciti, infatti, a trovare sempre sulle grandi questioni un punto di sintesi condiviso. Una vera e propria lezione pedagogica!
Come si sa, la Costituzione è stata scritta da esponenti appartenenti alle tre storiche dottrine politiche: liberale, cattolica e socialista. Eppure in ognuno dei 139 articoli del testo si coglie lo sforzo di uno spirito unitario, nettamente prevalente sui diversi orientamenti, spesso contrapposti. In particolare, i deputati dellâAssemblea Costituente hanno saputo anteporre sempre il bene del Paese allâinteresse di parte.
Da questo lavoro di scambio e di confronto, è uscito un documento considerato un modello di scrittura normativa, bello anche sul piano letterario. Il testo si fa poi apprezzare anche per la chiarezza, lâaccessibilità e la comprensibilità della lingua utilizzata.
Da un attento esame della Carta da parte di molti linguisti, tra cui Tullio De Mauro, si evince che essa contiene 9369 parole e i lemmi utilizzati appartengono per il 74% al vocabolario di base e solo il 26% a quello tecnico. Inoltre il piano di stesura riflette quello tipico della scrittura collettiva: periodi brevi, essenzialità , assenza di ridondanze, che conferiscono al testo âun alto livello di leggibilità â (De Mauro, 2011).
Inoltre, la Costituzione presenta una ricca struttura multidisciplinare. Convergono in essa differenti linguaggi che coprono lâenciclopedia di un intero curricolo scolastico: lingua, storia, diritto, arte, religione, educazione civica. In chiave educativa, tali discipline, intese come campi di significato, concorrono a valorizzare i saperi di responsabilità di cui parlava Maurizio Bettini e a scavare nel passato, non semplicemente per ricordarlo, ma per elaborarlo e praticarlo.
Ricostruire il senso del bene comune
Come sottolineato nel contributo del 2 febbraio u.s., ci sono poi alcune contingenze che portano a mettere al centro del percorso formativo dello studente lo studio della Costituzione.
La prima è il deficit di conoscenza che mina alla base il principio della cittadinanza culturale che ogni ragazzo deve solidamente possedere. La scuola non può non interrogarsi su questo vuoto. Gli insegnanti, infatti, sono i principali artefici dellâeducazione democratica e della formazione di un pensiero libero e critico: non possono, pertanto, abdicare alla trasmissione dei âfondamentaliâ che sono alla base del loro ruolo.
Una seconda ragione risiede nellâevidente crisi dellâassetto democratico che sta attraversando lâintero pianeta. âLâItalia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoroâ, recita lâarticolo uno della Costituzione. Come non interrogarci, quindi, sul significato che assume oggi lâespressione âRepubblica democratica?â.
Ripartire dai principi descritti nei primi dodici articoli significa non solo riannodare i fili della storia degli ultimi due secoli, ma anche far rivivere ai ragazzi la tensione che deve accompagnarli (oggi) nella costruzione di una polis solidale, aperta, partecipata. Siamo entrati in unâepoca in cui le democrazie, per diventare illiberali, non hanno più bisogno dei colpi di Stato. Come ha scritto il sociologo Maurizio Ferrera sul Corriere della sera, si può usare âuna lenta sequenza di tagli che rimuova, una dopo lâaltra, le garanzie liberaliâ (Ferrera, 2025).
Certo, i principi posti alla base della nostra Repubblica non vanno solo conosciuti, ma soprattutto agiti e testimoniati. Leggere, però, le questioni attuali attraverso la lente degli insegnamenti della Carta, ci aiuta a capire quanto sia importante mettere al centro dellâimpegno della scuola lâeducazione al bene comune e la città che è âdentro di noiâ.
La città interiore
Platone, in Repubblica, sostiene che lâuomo giusto costruisce la polis ideale, secondo i principi che egli custodisce nella sua âcittà interioreâ.
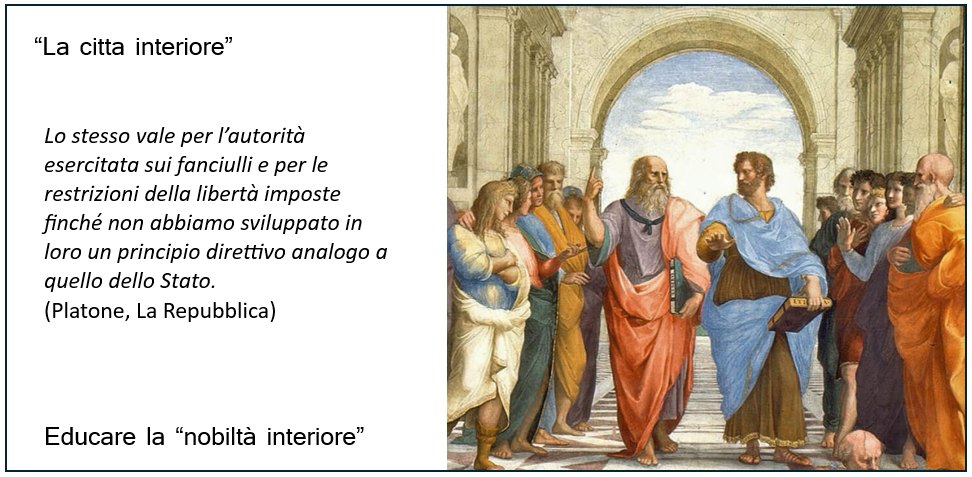
Il maestro, come rappresentato nellâimmagine, deve esercitare unâautorità liberante, che sappia educare al senso del limite e al presidio delle regole. Solo così lâalunno potrà vivere dentro di sé il âprincipio direttivo analogo a quello dello Statoâ.
Pertanto, uno studio serio della Costituzione ci aiuta anche a definire il perimetro di comportamenti virtuosi.
Spesso si afferma che il maestro insegna âciò che èâ. Ed è verissimo! Ma i docenti, per insegnare quello che sono, devono possedere solide conoscenze e creare le condizioni affinché gli alunni costruiscano la loro identità civica nellâacquisizione approfondita delle conoscenze stesse.
Sono proprio gli insegnanti a testimoniare la consapevolezza del ruolo formativo da essi esercitato e cercare, in modi convincenti, di portare ogni allievo a percorrere una strada ispirata a principi di giustizia, rispetto e prossimità .
Contenuti e valori⦠per un curricolo del Novecento
La centralità dellâapprendimento, metafora della società della conoscenza, ripresa in tutti i provvedimenti ministeriali degli ultimi decenni, non può essere disgiunta dalla qualità dellâinsegnamento. Pensare ad un curricolo del Novecento significa porsi due ineludibili domande: che cosa insegnare e come insegnare
Il primo interrogativo ci porta dritto al tema dei contenuti. Lâapprendimento, infatti, è sempre âapprendimento di qualcosaâ. Quel âqualcosaâ, come sottolinea Lucio Guasti, âdipende dalla possibilità operatoria del soggetto e non dalla quantità di informazioni che gli vengono messe a disposizione o imposte per essere appreseâ (Guasti, 2009). Il bravo insegnante riconosce in ciascun contenuto il âfareâ mentale e affettivo che ne caratterizza la dimensione formativa.
Lungi da noi pensare che un curricolo del Novecento si trasformi in una sequenza di lezioni espositive e di contenuti trasmessi. Anche se tutto ciò è, in parte, necessario. Ci sono molteplici modi per far rivivere la bellezza di un testo nellâattrattiva dellâimpegno civico: educazione outdoor, Service learning, progetti di comunità , patti territoriali ed altro. Conoscere, agire, testimoniare sono facce della stessa medaglia!
Alcuni riferimenti bibliografici
Ministero della Pubblica Istruzione (1997), Le conoscenze fondamentali per lâapprendimento dei giovani nella scuola italiana nei prossimi decenni. I materiali della Commissione dei saggi, Firenze, Le Monnier.
Hobsbawm E.J. (1991), Il secolo breve, Milano, Rizzoli.
De Mauro T. (2011), Costituzione, in Arcangeli M. (a cura di), Itabolario. LâItalia unita in 150 parole, Roma, Carocci.
Guasti L., (2009), Standards di contenuto nella scuola di base, Unâesperienza di ricerca a Reggio Emilia, Trento, Erickson.
Ferrera M., Il rischio della via illiberale, Corriere della sera, 9 febbraio 2025.



